Tre meravigliosi regali sepolti dal duo Baricco-Tornatore
Raccogliere i pensieri, trasformarli in parole, affiancarle perché insieme producano un testo più o meno chiarificatore.
Con questo film non si può. Chi l’ha visto, confermerà.
Dunque qual è il senso di scrivere di un’opera ventisei anni dopo la sua uscita nelle sale?
E perché farlo proprio adesso?
«Perché a Novecento quella famosa notte andò come va per i quadri: stanno su per anni, e poi, senza che accada nulla, ma nulla, dico… “FRAN”! Giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, però loro, a un certo punto, “FRAN”! Cadono lo stesso. Nel più assoluto silenzio, con tutto immobile intorno.»
Si tratta di una citazione (Max Tooney in dialogo con il negoziante) che mi aiuta a introdurre il primo dei tre macro-argomenti che rendono la pellicola del maestro Tornatore, tout court, un dono:
1) Accogliere dignitosamente la propria impotenza
Sono molteplici le scene capaci di sottolineare con notevole estro poetico questo semplice, non banale insegnamento. Penso, per esempio, a Novecento che, bambino in lacrime, enumera i buffi nomi dei cavalli da corsa al morente padre adottivo.
E ancora, Max Tooney che lascia andare l’amico al destino che egli ha scelto per sé, ossia la morte nel posto in cui è nato e ha vissuto.
Mi preme precisare che accettare di essere impotenti non significa affatto rassegnarsi; ne sono prova il comportamento e le azioni del trombettista interpretato da Pruitt Taylor Vince, il quale veste nell’economia del racconto un triplice abito: il ruolo (narratore interno) e l’incarnazione non di uno, bensì di due archetipi (angelo custode e guerriero).
Protegge Novecento, lo incoraggia, e infine lotta – tanto, senza risparmiarsi – forte della convinzione che questi sia ancora a bordo del Virginian, nascosto da qualche parte.
E ancora:
«Sapeva leggere Novecento, non i libri. Quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso, posti, rumori, odori. La loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, ordinava in quella immensa mappa che stava disegnandosi in testa. Il mondo magari non l’aveva visto mai, ma erano quasi trent’anni che il mondo passava su quella nave. Ed erano quasi trent’anni che lui su quella nave lo spiava. E gli rubava l’anima.»
2) Il silenzio come posto per celare i propri legittimi segreti
Cosa sapremmo di Novecento senza la voce di Max?
Il personaggio interpretato da Tim Roth funziona e resta indimenticato soprattutto perché non si esprime in prima persona. Nei pochi momenti in cui lo fa, il risultato è alimentare il mistero che ammanta la sua figura. Quando tace, il suo animo vaga nell’aria attraverso le note che produce con le dita. È corporeo, Novecento. Ed etereo. Carezza e insieme ombra.
Eppure ai naviganti non chiede impossibili restituzioni: mentre ne sequestra l’attenzione, si rimborsa segretamente figurandosi storie improbabili e divertenti sulle loro vite.
«Io ho imparato a vivere in questo modo.»
3) Coltivare l’incapacità di tradirsi per non cadere nella trappola del compromesso
Finalmente spiega, dipana la matassa, chiarisce.
Via via che le parole scorrono, l’intensità aumenta, l’emozione raggiunge il suo culmine.
Però l’impressione è che si tratti di una musica che ci ha già suonato.
E conclude:
«Perdonami amico mio, ma io non scenderò.»
Ha un sapore agrodolce, doppio, questa fine. Una sorta di epifania, rivelazione di una verità che ci era stata consegnata – vivida, pulita, asciutta – ma che abbiamo faticato a riconoscere perché comunicata nel linguaggio del divino.
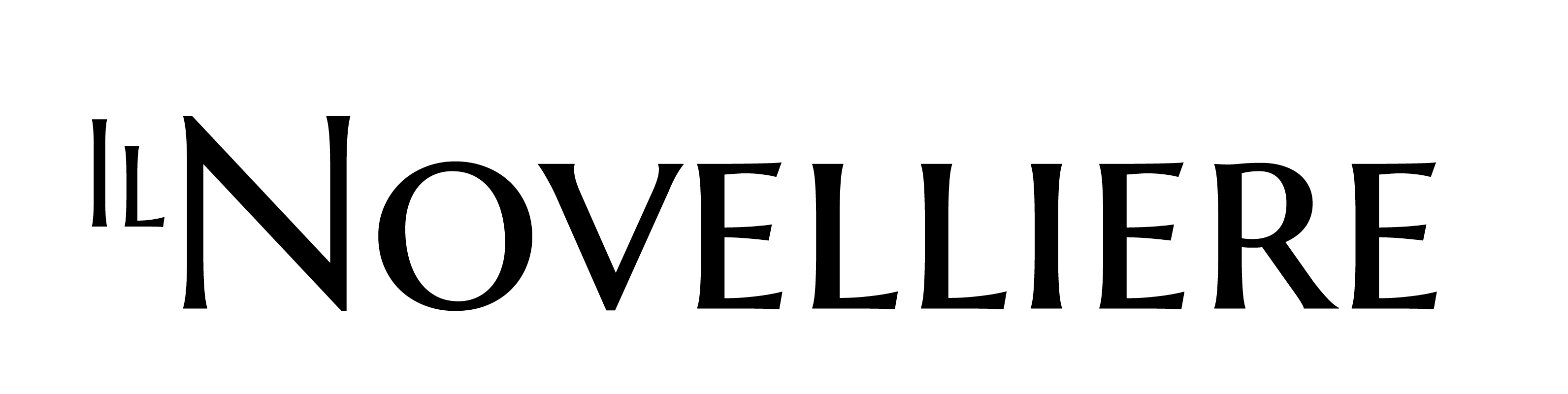

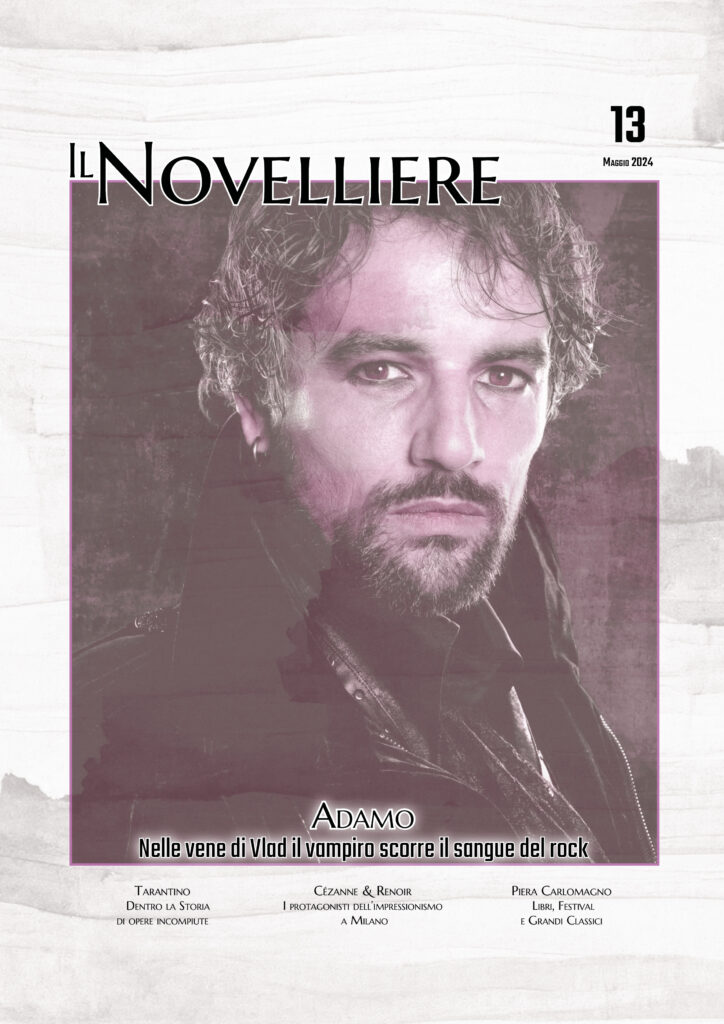
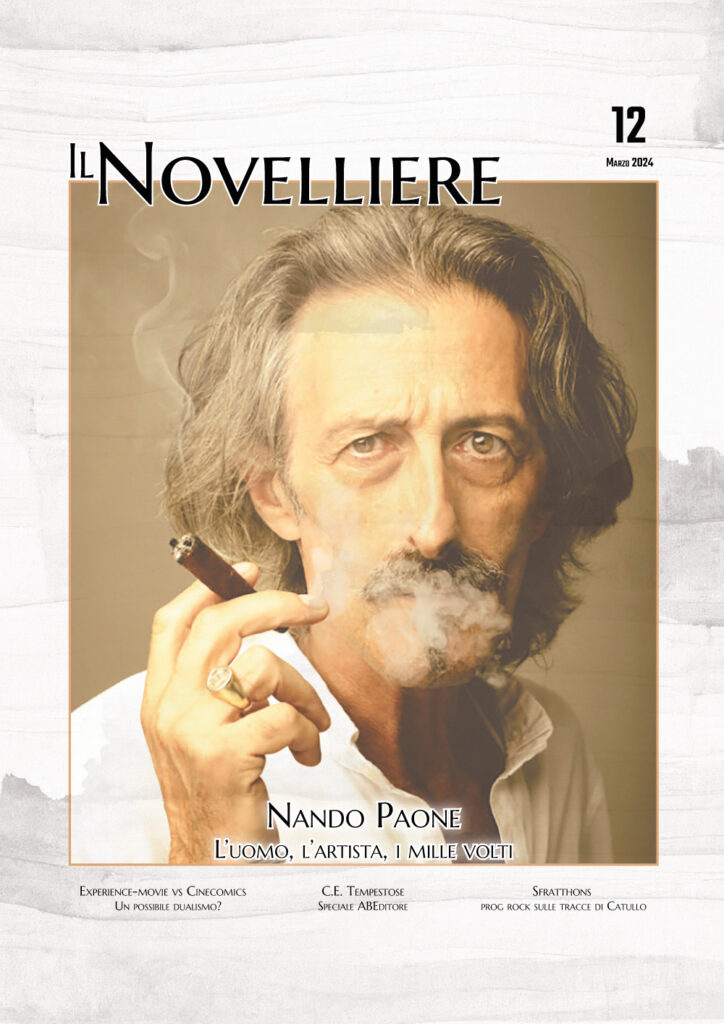
0 commenti